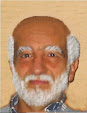Tali agglomerati di edifici, proprio a causa della posizione appaiono almeno suggestivi, quando non addirittura metafisici. Essi incuriosiscono e sollecitano la fantasia, e non solo la mia, a giudicare da quante persone mi abbiano chiesto informazioni, o abbiano semplicemente asserito di averli notati. Sono borghi rurali, che in Sicilia costituiscono il luogo virtuale nel quale le tre condizioni citate sopra, vastità, strade e latifondismo, si incontrano.
Alcune persone non sono, per carattere, in grado di esimersi dal cercare le risposte alle domande che inevitabilmente fanno seguito alla curiosità, ed io sono tra questi. Troverai qui una breve descrizioni di quale impulso interiore mi abbia spinto ad intraprendere questo viaggio. Ciò che non mi aspettavo era la sua evoluzione; la breve escursione presso alcuni tra i borghi dell’isola è divenuta un viaggio nel tempo e nello spazio, che mi ha catapultato nella Sicilia medioevale, costringendomi poi a risalire velocemente il corso degli eventi fino al ventesimo secolo. E durante il viaggio nel tempo ho avuto modo di rendermi conto del come e del perché la Sicilia sia divenuta ciò che è. Ho avuto modo di constatare come certi legami tra situazioni, certi nessi di causa ed effetto siano molto più stretti di quanto non appaia ad un’analisi più superficiale. Ritornato nel ventunesimo secolo mi sono reso conto (non senza un certo sgomento) delle dimensioni che aveva assunto il frutto delle mie esplorazioni, e della conseguente necessità di una sintesi; questo post intende appunto rappresentare una tale sintesi, sotto forma di sommario, con collegamenti che puntino ai vari, singoli, argomenti, o che vi punteranno quando verranno scritti.
La necessità di una tale sintesi si è comunque manifestata gradatamente, crescendo in maniera proporzionale alla mole dei dati raccolta. Molto prima che si materializzasse in questo post, essa aveva già assunto le forme di una classificazione. Non avendo personalmente né la veste, né le cognizioni per classificare ciò che vedevo, non ho potuto che riprendere i criteri di chi mi ha preceduto. La mia classificazione, che trovi qui, deve necessariamente riprendere in qualche modo i criteri adottati da coloro che hanno comunque costituito un riferimento durante lo svolgimento del mio impegno.
La classificazione segue, anche se non strettamente, un criterio temporale per catalogare i siti visitati. Uno degli aspetti importanti dell’adozione di tale criterio risiede nella possibilità dell’eliminazione di un errore di fondo presente nella memoria collettiva, che attribuirebbe al regime fascista la fondazione di centri che in realtà è avvenuta in tutt’altro periodo. Il fenomeno è così eclatante che ho voluto identificarlo usando il termine di “Errore”, con la “E” maiuscola. Dietro l’Errore vi è fondamentalmente il dato di fatto che il regime fascista fu la prima forma di governo ad esprimere una reale attenzione verso la classe contadina, ed a concretizzare tale attenzione con un piano di riforma. Pertanto, per i contadini siciliani, l’identificazione tra opere di riforma agraria e Mussolini è divenuta totale; troverai sempre qui una breve disamina delle cause che potrebbero aver generato l’Errore.
Una descrizione di ciò che ho veduto in questi anni non poteva prescindere da una seppur breve menzione di ciò che era accaduto precedentemente al Ventesimo secolo; ma soprattutto, non poteva prescindere da una breve descrizione dei rapporti tra latifondo e mafia rurale. Ho riassunto qui origini ed evoluzione di tali rapporti senza alcuna pretesa di correttezza o di completezza; l'argomento viene comunque ripreso più volte nel corso della descrizione delle singole fasi.
Ho infatti ritenuto che la classificazione da adottare dovesse operare una suddivisione in fasi; l'Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano, formalmente nato nel 1940, rappresenta il fulcro di essa.
Durante la prima fase furono creati borghi come città di fondazione, che poi evolsero in vere e proprie cittadine; gran parte dei paesi dell'interno della Sicilia ha avuto origine in tal modo
I borghi rurali fondati allora non conservano però nella stragrande maggioranza dei casi, le caratteristiche originarie
Queste sono in qualche modo riconoscibili negli impianti dei centri storici, che costituiscono il nucleo originale attorno al quale si é sviluppato il resto dell'abitato
La seconda fase, con la quale si giunge a ridosso del ventesimo secolo, ha visto nascere spontaneamente altri borghi, di solito nelle adiacenze di bagli e masserie, anche se questa non è una regola assoluta
Numerosi sono i borghi nati spontaneamente durante tale fase. Alcuni sono stati raggiunti dall’espansione di centri maggiori ed inglobati in questi ultimi; pochi sono stati abbandonati, vivendo l’ultima parte della loro esistenza come “paesini fantasma”
La terza fase
La maggior parte dei borghi visibili ed immediatamente riconoscibili come tali é stata costruita nella prima metà del ventesimo secolo. Il regime fascista ha giocato un ruolo centrale nella loro realizzazione, ruolo che é culminato nella nascita dell'ECLS.
Il fascismo ha sempre mostrato particolare attenzione verso l’agricoltura. Forse, come espresso qui, non direttamente verso i contadini; ma sicuramente verso il mondo rurale globalmente considerato.
Diverse cause avrebbero motivato una tale attenzione.
La prima, forse la principale, di esse sarebbe stata comune al mondo intero. La cosiddetta “globalizzazione” era lontana, nel tempo, quasi un secolo, e tutte le nazioni del mondo vedevano ancora nell’agricoltura la base del sostentamento materiale della popolazione. La simpatica abitudine di vivere vendendo telefoni cellulari e contratti per essi, ed ingerendo cibi coltivati a decine di migliaia di chilometri di distanza è recente; non era certo costume proprio delle popolazioni occidentali degli inizi del ventesimo secolo. Allora il modus vivendi era più tradizionale ed autoctono; quindi l’agricoltura risultava ancora, obiettivamente, la più importante delle attività umane.
Un’altra fondamentale motivazione risiedeva nella necessità di trovare un’occupazione per i reduci della prima guerra mondiale, rappresentati dall’Opera Nazionale Combattenti.
Nel corso del deprecato ventennio, si aggiunsero alle precedenti le necessità derivanti dall’autarchia e dalla limitazione delle importazioni. Ulteriori motivazioni si possono riscontrare in una sorta di particolare interesse che Mussolini sembrava nutrire nei confronti della società rurale. Tale interesse si sarebbe concretizzato anche in iniziative volte a favorire il trasferimento della popolazione dai grossi centri urbani a piccoli centri rurali.
Come viene più volte ribadito nel contesto di diversi post, non sono uno storico, non ho la pretesa di esserlo, né tantomeno ho la pretesa di condurre analisi storiche di una qualche validità; l’impressione che però ho tratto da ciò di cui sono venuto a conoscenza durante la mia avventura è che le problematiche inerenti all’agricoltura siano state, allora, valutate in una maniera più complessa di come lascino intendere certe sommarie descrizioni di ciò che accadde. Sicuramente in maniera più dettagliata ed approfondita di quella alla quale siamo stati abituati dai governi degli ultimi venti anni.
Contrariamente a ciò che è accaduto nel nostro (relativamente) recente passato repubblicano, infatti, chi venne chiamato ad occuparsi dei nuovi assetti da dare all’agricoltura italiana era riconosciuto come un esperto del settore; e ciò senza la necessità di scomodare i contemporanei “governi tecnici”, i quali, visti i risultati, di tecnico avrebbero anche ben poco. Seppur in una società antidemocratica e conservatrice come quella monarchica, diversi aspetti del problema vennero considerati, anche se non tutti, o almeno non tutti contemporaneamente.
La condizione del rurale era pessima da tutti i punti di vista; e lo era soprattutto quella del rurale siciliano. Totale dipendenza dal “padrone” senza alcuna garanzia, livelli di istruzione pari a zero, nessuna assitenza di tipo sanitario; mentre le terre rimanevano, spesso incolte, in possesso di un ristretto numero di persone.
Nel secondo decennio del ventesimo secolo, le questioni relative alle necessità dei reduci di guerra ed alle possibilità temporanea assegnazione di terreni incolti ai contadini vennero affrontate dall’Opera Nazionale Combattenti, e con la promulgazione del decreto Visocchi; un breve accenno ad ambedue viene fatto qui.
Le problematiche relative alla disponibilità delle terre presentavano due aspetti diversi. Uno era relativo alla proprietà dei terreni da assegnare; l’altro era inerente alle condizioni dei terreni. I due aspetti potevano intersecarsi, in quanto alcuni proprietari potevano mantenere il possesso di terreni la cui condizione non ne consentiva l’utilizzo in senso agricolo.
Il processo di trasformazione delle terre non coltivabili, perché paludose, aride o malsane , in terreno fertile introdusse il concetto di “bonifica integrale”.
Nel secondo decennio del ventesimo secolo, il concetto di bonifica integrale indicò la possibilità, in senso lato, della colonizzazione di un territorio, comprendendo anche le realizzazioni volte a risolvere anche le problematiche di natura sanitaria, sociale ed economica del mondo rurale, cioè la lotta alla malaria, le strutture residenziali, quelle di servizio, e le opere necessarie al loro funzionamento. Le terre dovevano quindi essere non solo coltivabili, ma anche abitabili, consentendo così che venissero popolate. L’applicazione pratica di tale concetto trovò la massima espressione nella bonifica dell’Agro Pontino. Il regime, nel perseguire tali interessi, si avvalse di tecnici, tra i quali Arrigo Serpieri
In Sicilia, qualunque tentativo di risoluzione delle problematiche sopra menzionate si scontrava con un problema ben maggiore, apparentemente costituito dai proprietari terrieri, i grandi latifondisti.
Riguardo a quest’ultimo problema, il regime fascista ritenne di poter individuare una soluzione nell’inviare in Sicilia Cesare Mori, il plenipotenziario “prefetto di ferro”; qui viene accennato alla vicenda.
Nel primo quarto del ventennio fascista, l’azione di rilancio dell’agricoltura, in Sicilia, si dimostrò alquanto scoordinata. L’attività principale consisteva nelle opere di bonifica stricto sensu (risanamento delle paludi, impianti per irrigazione dei terreni aridi, lotta alla malaria). Ciò avrebbe dovuto venire condotto assistendo i proprietari nelle opere di bonifica. L’assistenza sarebbe stata mediata dai Consorzi, e per fornirla venne fondato l’Istituto VEIII per la bonifica della Sicilia. La realizzazione dei centri rurali consistette in questa fase in un tentativo di riconversione, di riutilizzo, degli edifici costruiti per ospitare gli operai della bonifica; essa non si avvalse quindi dell’opera dell’Istituto VEIII
La quarta fase
Al termine della prima metà del ventennio l’azione pare farsi maggiormente incisiva, nella propaganda, ma anche nella pianificazione, compresa quella relativa alle migrazioni interne.
Probabilmente all’inizio dell’esperienza fu ritenuto semplice ciò che in realtà non lo era. Le migrazioni interne, che sarebbero dovute avvenire spontaneamente sulla base di un incentivo, ottennero risultati inferiori alle aspettative. I metodi per sfollare le città si sarebbero dovuti sviluppare allora su binari paralleli: all’incentivo a migrare avrebbe dovuto corrispondere il disincentivo a rimanere.
In Sicilia, l’operazione si rivelava particolarmente difficoltosa, a causa di un particolare risvolto, non operante nelle altre regioni d’Italia. Mentre altrove il popolamento delle campagna spesso significava il trasferimento di agricoltori in piccoli centri rurali, agglomerati di case costruite intorno ad nucleo di servizi essenziali (scuola, chiesa uffici) realizzando minuscoli villaggi a funzione mista (residenziale e di servizio) in Sicilia il concetto di “borgo” doveva riguardare esclusivamente le strutture di servizio, con l’assoluto divieto di costruire gruppi di case coloniche, limitando così i contatti tra i singoli a luoghi di incontro ben determinati. Le dimore per le famiglie di agricoltori dovevano sorgere, isolate, sul fondo da coltivare.
Formalmente una tale filosofia viene fatta risalire al progetto di “Città Rurale” di Edoardo Caracciolo, ma sostanzialmente essa compare in Sicilia ben prima della formulazione dell’idea dell’architetto; e per una (strana) coincidenza tale concezione fa la sua comparsa poco dopo il termine delle operazioni condotte dal prefetto Mori. Infatti, almeno un decennio prima della pubblicazione del testo di Caracciolo veniva già enfatizzata l’assoluta necessità di disperdere le famiglie contadine sul territorio. Perché mai un tale atteggiamento? E perché tale necessità non sembrava emergere in altre regioni d’Italia?
Nei fatti una tale concezione della società rurale siciliana si trova negli scritti di Guido Mangano, allora direttore dell’Istituto VE, per il quale, ai fini del “bonificamento” risultavano indispensabili “il trasferimento e la fissazione dell’intera famiglia colonica sulla terra”
Mangano chiaramente avverserà la riconversione dei villaggi operai, riconversione che avrebbe dato luogo a borghi misti. Ma, praticamente, (quasi) nessuna realizzazione si deve all’Istituto VEIII. I “borghi” costruiti durante quella che ho denominato “quarta fase” sono in realtà anch’essi villaggi riconvertiti, ma progettati in maniera da essere funzionali alla riconversione. Poiché consistono in diverse case coloniche (originariamente case cantoniere) più un edificio servizi, non seguono i dettami dell’Istituto VEIII relativamente alla dispersione degli agricoltori sul territorio. Anche la loro origine non ha quindi nulla a che vedere con l’Istituto
Prescindendo dagli eventi strettamente confinati alla Sicilia, comunque, durante la prima metà del Ventennio si fa progressivamente più pragmatico l’approccio a tutte le problematiche che la bonifica integrale coinvolge. Dalla sanità
I villaggi minerari
Sono stati qui brevemente menzionati anche i villaggi minerari progettati dal regime. Nel post viene manifestato il concetto che mi ha condotto ad includere tali realizzazione nella serie sui borghi rurali. Ma al di là dei caratteri comuni che riguardano l’ubicazione, in campagna, e gli occupanti, anch’essi esponenti del proletariato, vi è un’ulteriore motivazione che mi ha spinto a menzionarli. Nel corso della visita ad uno di essi, infatti, mi sono imbattuto in una delle più eclatanti manifestazioni dell’Errore. L’edificazione dei villaggi minerari, infatti, sebbene pianificata dal regime fascista, avvenne quasi interamente nel dopoguerra.
Un fenomeno del quale non ho trovato ancora spiegazione è che più del novanta percento degli accessi al post sui villaggi minerari avviene dal Brasile; ne ho dedotto che avrò inconsapevolmente inserito qualcosa, nel post, che deve avere un significato particolare in portoghese.
La quinta fase
Nel gennaio del 1940, formalmente, l'Istituto Vittorio Emanuele per la Bonifica della Sicilia transitò nel neonato Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano; sostanzialmente, però, tale transito era avvenuto più di tre mesi prima. Lo scopo dell'ECLS non era solo quello di assistere i proprietari nelle opere di bonifica, ma anche quello di supportarli nella realizzazione delle infrastrutture, ma soprattutto quello di sostituirsi ad essi in tali realizzazioni se essi fossero stati inadempienti. L'ECLS avrebbe dovuto curare la realizzazione delle opere di competenza pubblica e contribuire a quelle di competenza privata. Nel caso uno o più proprietari fossero stati espropriati, l'ECLS sarebbe divenuta nel contempo anche parte privata
i borghi progettati (e realizzati) dall’ECLS continuarono a seguire la filosofia dell’Istituto VEIII, che anzi trovò una codifica ufficiale nella “Città rurale” di Caracciolo. I borghi ECLS furono quindi esclusivamente “borghi di servizio”, privi di unità abitative per i contadini, anche se in qualche caso l’impostazione del borgo, pur rimanendo il nucleo formalmente costituito dagli edifici di servizio, sostanzialmente si configurava come borgo a funzione mista.
La motivazione del persistere di una tale impostazione, nonostante le diverse convinzioni del Direttore dell’Ente, appare inspiegabile; tanto più che Mazzocchi Alemanni mostrava, nell’incarico che gli era stato assegnato, autonomia decisionale e determinazione, le stesse che aveva esibito durante la bonifica dell’Agro Pontino.
Nel primo anno di attivitá, l'ECLS realizzó otto borghi rurali, uno per provincia, con l'esclusione della provincia di Ragusa: Borgo Schiró (PA), Borgo Bonsignore (AG), Borgo Fazio (TP), Borgo Gattuso (CL), Borgo Cascino (EN), Borgo Giuliano (ME), Borgo Rizza (SR), e Borgo Lupo (CT), dando così inizio a quella che ho denominato quinta fase
La costruzione dei sette borghi iniziati nel 1941 fu interrotta dalla seconda guerra mondiale e riprese, con alterne vicende, al termine del conflitto
Ovazza prima, e Rosario Corona poi, si occuparono essenzialmente del completamento dei borghi del 1941 e della riparazione dei danni di guerra; l'unico borgo progettato dall'ECLS nel periodo post-bellico fu Borgo Africa (AG), anch'esso mai realizzato e pertanto incluso tra i "fantasmi dell'ECLS".
Mazzocchi Alemanni, in un certo modo, continuerà a rimanere un riferimento, e continuerà ad esprimere la propria concezione riguardo ai borghi rurali. Questo è, ad esempio, un estratto del discorso di Grieco al Senato, come riportato da “l’Unità” del 7 febbraio 1950
La settima fase
E l’ERAS, oltre a farsi interprete delle ultime volontà dell’ECLS, sembrò anche raccoglierne l’eredità, almeno sempre per ciò che riguarda i borghi. Ne edificò un certo numero, anche se più piccoli (quasi esclusivamente di tipo “B”), che rispecchiavano nell’impostazione e tentavano di ricalcare nell’architettura quanto era stato prodotto dall’ECLS.
L’unico borgo di tipo “A” realizzato in questa fase fu Borgo La Loggia in contrada Grancifone, Vi sarebbe, come borgo di tipo "A", anche Libertinia; ma i servizi di Libertinia si avvalevano in parte delle strutture preesistenti, realizzate negli anni Trenta.
L’ERAS aveva comunque sviluppato un piano capillare di edilizia rurale, che avrebbe coperto di raggi d’influenza l’intera superficie dell’isola. La realizzazione dei borghi di tipo “A” sarebbe però stata prevalentemente devoluta ad altri Enti, soprattutto ai Consorzi. Nella mappa redatta dall’Ente ed aggiornata al 1 gennaio 1956, risultava a carico dell’ERAS la costruzione di borghi di tipo “B” o “C”. Era prevista infatti, sempre a carico dell’ERAS, anche la realizzazione di diverse case coloniche, spesso a breve distanza l’una dall’altra, ed a volte raggruppate a formare villaggi
L’ottava fase
Un assunto sembrava infatti essere venuto meno: l’assoluto divieto all’aggregazione dei contadini. E’ evidente che le condizioni che rendevano necessario tale divieto erano mutate. Probabilmente gli interessi di chi gestiva l’agricoltura siciliana convergevano altrove; gestire “politiche agricole” stava divenendo più conveniente (e più remunerativo) che gestire agricoltura ed agricoltori.
Tra i servizi eliminati nella quasi totalità dei borghi dell’ultimo periodo vi fu quello religioso, eliminando ciò che nel mondo rurale aveva sempre rappresentato un punto di aggregazione. I borghi di tipo “C”, che avrebbero compreso chiesa e scuola, furono di fatto ridotti alla costruzione di scuole rurali; in questo, l’ERAS non fece altro che sostituirsi allo Stato, che già negli anni Venti si era curato della realizzazione di esse, compito poi nei fatti devoluto all’ECLS, che le aveva incluse tra i servizi essenziali che ogni borgo avrebbe dovuto erogare.
La fase parallela
Vi fu però una “fase parallela” che durò quasi mezzo secolo, contemporanea alle ultime tre fasi, ma per la quale le regole del periodo sembravano comunque non valere. Gli insediamenti descritti a proposito di questa fase risultano essere quelli che da altri (Dufour, La China, Samuels) vengono classificati come "privati"; ma ciò non è casuale. Quando vigevano determinate condizioni, oppure quando non ne vigevano altre, gli assunti e le pianificazioni perdevano la loro importanza, e le regole non scritte potevano venire violate. Era non solo possibile, ma persino auspicabile, che i contadini vivessero nel medesimo agglomerato urbano. Era consentito mantenere gli insediamenti preesistenti se le condizioni lo richiedevano, così come poteva divenire imperativo eliminarli se le condizioni mutavano. E cosa venisse realizzato e cosa no, era subordinato all’interesse di alcuni, non a quello dell’agricoltura. Ciò avvenne con la progettazione di Mussolinia, nei pressi di Caltagirone, per riproporsi con Libertinia, con Santa Rita, con il villaggio Pergusa
I Consorzi
La fase dello “sperpero dell’eredità” è stata così definita con riguardo a ciò che l’ERAS e l’ESA, in quanto figlio e nipote dell’ECLS fecero o non fecero in Sicilia, ed a quanto denaro pubblico venne impiegato in progetti o realizzazioni sostanzialmente inutili. Ma nello stesso periodo si fece più evidente la presenza dei Consorzi, la cui attività era stata inibita in passato da quella, accentratrice, dell’ECLS, ed ai quali, invece, l’ERAS aveva evidentemente pensato di demandare diverse attività. Sono quindi i borghi dei Consorzi gli ultimi ad essere costruiti; sono questi, la cui esistenza è spesso misconosciuta, a segnare la fine definitiva di queste realizzazioni in Sicilia.
Accanto ad essi continuarono ad operare le scuole rurali (la cui esistenza viene appena sfiorata, insieme a quella di altri centri rurali, nell'epilogo), la cui realizzazione ed organizzazione si sviluppò per quasi un secolo, per iniziativa di stato, enti o consorzi. La fine dell’epopea dei borghi rurali coincide con la progressiva chiusura degli istituti elementari delle campagne, ambedue in stretto rapporto con una tendenza esattamente opposta a quella che fascismo avrebbe voluto favorire: lo spopolamento delle campagne, l’urbanizzazione, e l’emigrazione all’estero. La fine di ciò che l’agricoltura siciliana, nel bene e nel male, era stata per secoli.
Tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta si assistette alla progressiva meccanizzazione del’agricoltura. A questa avrebbe dovuto corrispondere un adeguamento della pianificazione della riforma agraria. La meccanizzazione dell’agricoltura si concretizzava in pratica in un’industrializzazione della stessa; e come accade in tutte le attività industriali rispetto a quelle artigianali si assisteva ad un incremento dei costi fissi (nel caso specifico, acquisizione e manutenzione delle macchine) che si sviluppava parallelamente ad un incremento della capacità produttiva (possibilità per un singolo individuo di curarsi della coltura di maggiori estensioni di terreno). Di solito, in tali condizioni si cerca di massimizzare la produzione per ridurre l’incidenza dei costi fissi di produzione: se con un trattore ed un aratro meccanico si riescono ad arare venti ettari di terreno anziché dieci, la spesa relativa al mezzo meccanico inciderà per la metà su ogni unità di produzione. Sebbene dovesse essere ovvio che l’incidenza dei costi fissi si riduce all’aumentare della produzione, l’estensione dei poderi concessi ai contadini si ridusse grandemente rispetto a quella prevista dalla riforma fascista.
La prima, inevitabile, conseguenza fu l’emigrazione. Non era possibile vivere con i proventi derivanti da appezzamenti di terreno così piccoli. La seconda conseguenza (consequenziale alla prima), fu la fine dell’agricoltura siciliana così come era esistita fino alla metà del Ventesimo secolo; ma in un mondo che si preparava alla globalizzazione, ciò appariva di un’importanza del tutto secondaria.
L’epilogo, in molti casi, consistette nella ricostituzione del latifondo. Molte proprietà che erano state frammentate vennero ricomposte, “convincendo” gli assegnatari a cedere i terreni ricevuti, avendo dalla propria parte la legge ed anche la forza. La legge prevedeva che la vendita dei terreni di cui l’assegnatario era divenuto proprietario considerasse in posizione prioritaria chi possedeva i poderi viciniori; e spesso, chi possedeva i poderi viciniori portava cognomi “famosi”, o aveva qualche parente con cognome “famoso”. Ma di tutto questo, il governatore Crocetta sembra essersi reso conto solo di recente
E questo, Lettore, appare come la chiusura di un cerchio. Sembra di essere ritornati ad uno dei post iniziali (la mafia, il latifondo). Nulla è cambiato, e nulla cambierà. Come un trasformista in grado di cambiare radicalmente veste ed aspetto, ma la cui abilità nel far ciò è dovuta all’individuo che sta sotto le vesti. Che rimane, sempre e comunque, il medesimo.
Detto questo, qui non mi rimane altro da dire. E non mi rimane altro da mostrare se non una mappa che riporta la posizione di molti degli insediamenti citati nel testo.
Ho tralasciato i borghi antecedenti al Ventesimo secolo ed i villaggi minerari. I siti sono riportati in diverso colore e con simboli diversi i siti realizzati nelle varie fasi. Alcune delle realizzazioni degli ultimi periodi, quando venne abolito il veto riguardo all’aggregazione della popolazione rurale, sono, almeno sostanzialmente, dei borghi misti (residenziali e di servizio); il simbolo che li individua è il triangolo. In diverse zone dell’isola, sono stati realizzati agglomerati con esclusiva funzione residenziale; essi sono identificati dal simbolo della casetta. Questa è la legenda della mappa.
La mappa non ha ovviamente la pretesa di voler fornire alcuna indicazione utile all’identificazione delle posizioni precise; non è pensata avendo in mente l’idea dell’individuazione topologica dei luoghi. Serve solo a rendere graficamente quale sia l’ordine di grandezza, in senso numerico e geografico, di ciò che venne eseguito. Conseguentemente, si può avere un’idea anche dell’impegno che è stato necessario per portare a termine la serie sui borghi.
Devo sottolineare che senza il supporto degli strumenti messi a disposizione sul Web, soprattutto il Geoportale Nazioneale e GoogleEarth, il lavoro sarebbe stato sicuramente incomparabilmente più lungo e difficile, probabilmente impossibile. So bene che dietro tali strumenti vi sono persone; persone che non conosco ma alle quali va comunque il mio ringraziamento. Così come il mio ringraziamento va a diverse persone che conosco, e che in diversa misura, a volte persino inconsapevolmente, hanno fornito supporto e contributo a questa serie di post.
Innanzitutto Cinzia Cicero, senza l’apporto della quale tutto ciò probabilmente non sarebbe mai avvenuto.
E poi il prof. Vincenzo Sapienza, la cui gentilezza è stata in grado di generare spontaneamente un flusso di informazione (da lui a me, evidentemente) assolutamente determinante ai fini di questo lavoro
Joshua William Samuels, che, oltre a rappresentare un’insostituibile sorgente di dati, ha costituito uno stimolo non indifferente ad approfondire l’argomento.
Ma soprattutto l’ing. Angelo Morello la cui gentilezza e disponibilità, oltre a fornire direttamente e consentirmi l’accesso a molte informazioni, lo ha reso piacevole e costruttivo interlocutore in lunghe conversazioni.
Ed insieme a lui, all'ESA, la d.ssa Bergamaschi, il dott. Inzerillo.
Anche il titolo che ho dato alla serie, “La Via dei Borghi”, intende essere un tributo al lavoro dell’ESA, e non una forma di plagio.
Il sig. Matteo Dino, che mi ha sopportato durante le ricerche di archivio, ed il sig.Cannariato, che ha costretto il sig. Dino a sopportarmi.
Vittorio Riera, della conoscenza del quale mi ritengo onorato.
La simpaticissima Marilena La China, delle cui competenze mi sono avvalso, magari sfruttando un po’ la sua naturale disponibilità.
L’architetto Orlando del comune di Castronovo di Sicilia; così come la sig,ra Saimbene del comune di Caltagirone. Ambedue di una cortesia non comune.
La dottoressa Fiorella Scaturro. già direttore dell'ASCEBEM. per la disponibilità e la gentilezza mostrate.
Il sig, Candela di Fulgatore, che ha un senso dell’ospitalità eccezionale, nel senso più letterale dell’aggettivo.
Ringrazio inoltre il personale della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, che riesce a rendere più rapido ciò che ad un primo impatto appare come un’impresa lunga e tediosa.
Ringrazio anche le persone che ho incontrato nel corso di questa avventura, che spesso mi hanno accompagnato personalmente sui luoghi da visitare e da fotografare, senza chiedersi e chiedermi nulla, con la naturalezza e la gentilezza di chi risponde semplicemente ad una domanda. E’ accaduto a Borgo Bonsignore, a Santa Rita, a Pergusa, a Borgo Petilia, a Borgo Cascino, a Borgo Lupo, a Libertinia, a Borgo Pasquale, a Santa Barbara…
Ma soprattutto ringrazio di cuore coloro che non ho menzionato qui. Coloro che hanno fatto qualcosa per me, ma dei quali non riesco a ricordarmi mentre scrivo. Qualunque sequenza di eventi che conduca ad una condizione migliore, grande, piccola, importante, trascurabile che sia, non sarebbe realizzabile senza il contributo di tante persone delle quali poi non ci si ricorda più. Magari il contributo del singolo è modesto, ma la somma di tutti i contributi si unisce a formare quella spinta propulsiva senza la quale nulla sarebbe possibile. Non sarebbe possibile una banalità come il mio viaggio tra i borghi di Sicilia, così come non sarebbero possibili le più grandi conquiste dell’umanità. A loro, il mio grazie dal più profondo del cuore.